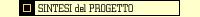
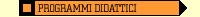
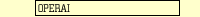

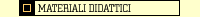

 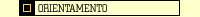
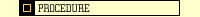
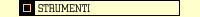
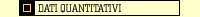
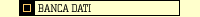
|
 
|
|
FORMAZIONE
APPRENDISTI IMPIEGATI
|
 |
 |
| |
IL
gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro è stato costituito, su mandato
del Formedil Nazionale, dal Formedil Regione Lombardia,
e si è insediato il 19.01.99 dopo un incontro preparatorio
svoltosi a Milano nel dic. 98 alla presenza dell’ arch.
Giovanni Carapella e della dott.ssa Rossella
Martino del Formedil Nazionale
Il gruppo, coordinato da
ESPE di Como dott. arch. Vincenzo Colardo coordinatore
è composto dai seguenti Enti Scuola Lombardi che
ne hanno nominato i rispettivi incaricati nelle seguenti
persone:
ENTE SCUOLA EDILE DI BERGAMO: ing. Ivan Barcella.
ENTE SCUOLA EDILE DI BRESCIA: arch. Aldo Palladini.
ESPE - ENTE SCUOLA EDILE DI COMO: dott. Antonio Moglia,
p.e. Pietro Millesimi, geom. Francesco Ferrario, geom. Giorgio
Migliavada.
ENTE SCUOLA EDILE DI CREMONA: geom. Giuseppe Meola, sig.
Luigi Lipara.
ESEM - ENTE SCUOLA EDILE DI MILANO: arch. Ennio Rigamonti.
ESEDIL - ENTE SCUOLA EDILE DI PAVIA: geom. Valerio Folcato.
ENTE SCUOLA EDILE DI VARESE - CPT VARESE: sig. Pierangelo
Reguzzoni
La progettazione dei singoli moduli è stata curata
dagli incaricati delle seguenti scuole edili
| Modulo A |
: Como |
| Modulo B |
: Varese + Cremona |
| Modulo C |
: Milano |
| Modulo D |
: Milano |
| Modulo E |
: == |
| Modulo F |
: Como |
| Modulo G |
: Como |
| Modulo H |
: Como + Milano |
| Modulo I |
: Bergamo +Milano |
| Modulo L |
: Bergamo |
| Modulo M |
: Bergamo + Cremona + Varese |
| Modulo N |
: Brescia |
| Modulo O |
: Milano |
| Modulo P |
: Como + Cremona |
| Modulo Q |
: Brescia |
| Modulo R |
: Como |
| Modulo S |
: PAVIA |
|
|
|

|
| |
Obbiettivi
del gruppo di lavoro
Trattandosi di un progetto sperimentale, il gruppo di lavoro,
si è posto in generale l’obiettivo di contemperare
una doppia esigenza:
| 1. |
da
un lato quella di fornire un progetto sufficientemente
articolato e dettagliato, che potesse costituire una
sicura traccia di riferimento per l'attuazione dei
moduli formativi previsti, |
| 2.
|
dall'altra
quella di far sì che il progetto, al di là
di ogni velleitarismo, fosse al tempo stesso sufficientemente
flessibile ed adattabile alle singole realtà
locali, pur nei limiti definiti da un quadro generale.
Il progetto, infatti in quanto sperimentale, potrebbe
far sorgere la tentazione di andare a definire le
azioni formative fin nei minimi dettagli, con ciò
correndo il rischio non solo di una eccessiva rigidità,
in definitiva di una sua scolasticizzazione, ma anche
di commettere un errore metodologico. |
Il
gruppo si è posto poi obiettivi definibili di breve,
medio e lungo periodo
Quelli di breve periodo:
| • |
fornire lo schema generale dei percorsi formativi,
separatamente per impiegati tecnici ed ammnistrativi,
composti dai diversi moduli, |
| • |
definire
per ogni modulo formativo gli obiettivi generali e
i contenuti in modo da costituire un sicuro riferimento
per tutte le scuole edili coinvolte nel progetto.
|
Per il medio periodo:
| • |
realizzare
il censimento dei supporti didattici utili e disponibili,
attraverso la diffusione di un questionario da sottoporre
alle scuole edili, e i cui risultati saranno raccolti
in una banca dati che sarà posta a disposizione
di tutti. Va da sé la ovvia considerazione
che ove siano stati predisposti supporti didattici
lì è presumibile che vi sia anche un
patrimonio di conoscenze attivabili |
| • |
Presentare
il progetto e renderlo trasferibile in rete internet
tramite il Formedil |
Per il lungo periodo:
| • |
Fornire
tutto quanto sarà ritenuto utile per l’implementazione
del progetto, il tutto da definirsi anche in funzione
dei risultati del questionario e delle necessità
che si riveleranno più urgenti. |
| • |
organizzare
sia un monitoraggio che uno scambio di informazioni
tra le scuole che attuano il progetto, sui suoi esiti
attuativi, preferibilmente su base telematica e per
i momenti di sintesi più significativa in riunione
plenaria, |
| • |
programmare
le opportune azioni per il miglioramento continuo
del progetto, e ciò sia in generale per l'intero
corso, sia in modo più specifico per i singoli
moduli |
|
|
|

|
| |
Note
metodologiche
Il gruppo di lavoro ha operato su un mandato abbastanza
ampio, secondo la seguente metodologia:
| 1. |
Riesame collegiale
delle esigenze, esplicite ed implicite, dei Committenti
(Formedil e Ministero) e degli Utenti, anche alla
luce delle finalità del progetto e delle normative
di riferimento vigenti |
| 2. |
Riesame collegiale dei
15 moduli individuati in linea di massima nel progetto
sperimentale approvato dal Ministero e dei nuovi 5
moduli, emersi in fase di progettazione esecutiva,
con il proposito di: |
| |
•
|
Verificare gli obiettivi
generali perseguibili attraverso i singoli moduli,
dati i tempi stabiliti di 24 ore/modulo |
| |
• |
Individuare le eventuali
carenze di contenuto nel quadro complessivo del progetto
e proporre possibili integrazioni |
| |
• |
valutare la possibilità
di contenere gli argomenti previsti nel tempo imposto
di 24 ore/modulo |
| |
• |
Verificare della corretta
titolazione dei singoli moduli2.4. Verificare della
corretta titolazione dei singoli moduli |
| |
• |
Attribuire i singoli
moduli ai percorsi formativi dei tecnici o degli impiegati |
| 3.
|
Affidamento ai componenti
del gruppo designati dalle singole scuole dell'elaborazione
dei singoli moduli per la puntuale definizione: |
| |
• |
dei contenuti tematici
|
| |
• |
della loro articolazione
nelle singole unità didattiche |
| |
• |
delle metodologie didattiche
suggerite |
| |
• |
delle strumentazioni,
della logistica e dei docenti da impegnare nell'attività |
| 4. |
Verifica collegiale delle
elaborazioni svolte secondo gli indirizzi illustrati
al punto precedente condotte esclusivamente per evitare
una sovrapposizione o duplicazione di contenuti. |
| 5.
|
Definizione collegiale
dei definitivi percorsi formativi, separatamente per
impiegati tecnici ed amministrativi, attraverso l’aggregazione
degli specifici moduli (in parte obbligatori ed in
parte facoltativi) |
Ovviamente
tutto ciò non può essere e non deve essere
considerato esaustivo, ma piuttosto un primo passo che dovrà
costituire materia di successiva riflessione ed approfondimento
da parte del gruppo e del Formedil per un miglioramento
che potrà essere apportato anche attraverso quel
lavoro di riscontro e di validazione da parte delle scuole
edili che attueranno il progetto. |
|
|

|
| |
Avvertenze
all'utilizzazione dei percorsi didattici e dei moduli
progettati
I percorsi didattici
formalmente organizzati sono tre:
- per
impiegati amministrativi,
- per
tecnici prevalentemente di cantiere
- per
tecnici prevalentemente gestionali
E'
quindi possibile orientare il percorso formativo non solo
in funzione delle esigenze generali, ma anche in funzione
delle esigenze dell'aula, scegliendo tra i vari moduli
disponibili quelli più rispondenti alle specifiche
necessità.
I moduli sono stati elaborati senza perdere mai di vista
il quadro complessivo di riferimento, assicurando quindi
la loro integrazione ed evitando, per quanto possibile,
inutili sovrapposizioni di contenuto. Si sono anche tenute
in considerazione le necessarie integrazioni tra le figure
di impiegati amministrativi e tecnici.
I moduli progettati vanno utilizzati
con alcune avvertenze
| 1.
|
I "contenuti"
dei singoli moduli sono solo quelli strettamente
operativi. Potrebbe apparire forse superfluo, ma
si ritiene utile sottolineare che sarà opportuno
prevedere, da parte dei singoli attuatori, almeno
due accortezze: |
| |
|
La prima di carattere generale,
riferite all’intero corso, reperendo
il necessario spazio da
dedicare all'accoglienza (illustrazione generale
del corso, rinforzo della motivazione, stimolo
della curiosità dei partecipanti, ecc…),
spazi intermedi e finali di riflessione
sulle attività attuate per raccogliere
i necessari elementi di valutazione che dovranno
far parte di un monitoraggio globale
|
| |
|
La seconda è
di carattere particolare, riferita ai singoli moduli.
Come dicevamo, i contenuti ed i tempi sono stati
riferiti strettamente agli elementi di natura conoscitiva.
Anche in questo caso occorrerà prevedere
sia adeguati momenti introduttivi che di validazione
finale per consentire un miglioramento continuo
del progetto. |
| 2.
|
|
Appare altrettanto ovvio
suggerire che, pur nel rispetto dei tempi previsti
dai moduli, la programmazione didattica, dovrà
essere necessariamente articolata, in modo da garantire
(ad esempio) l'alternanza di docenti, di argomenti,
di metodologie didattiche (lezione frontale, esercitazione
assistita, simulazione, role-playing, ecc), in funzione
della curva di attenzione, dell'interesse dell'aula,
ecc. |
| 3.
|
|
Infine, detto per inciso,
sarebbe poi opportuno iniziare a pensare ad una
adeguata formazione dei docenti. Ricordiamo infatti,
che, specificamente nella formazione di apprendisti
impiegati, siano essi tecnici o amministrativi,
i docenti si rivolgono a persone provenienti dalla
scuola media superiore, e nella formazione continua
a persone maggiorenni, e pur se sappiamo che i processi
di apprendimento non differiscono tra il bambino
e l'adulto, sappiamo però che le metodologie
didattiche da adottare (e soprattutto il comportamento
del docente) per favorire il processo di apprendimento
sono ben diverse. Se le scuole edili hanno sviluppato
le loro principali competenze formative prevalentemente
nella formazione di base, ed in genere nella formazione
di adolescenti, è forse giunto il momento
per un riorientamento mirato. |
|
|
|

|
| |
Note
di suggerimento per l'implementazione del progetto
E' indubbio che la riforma dell'obbligo
scolastico, e le nuove caratteristiche del contratto di
apprendistato, accresceranno e modificheranno i principali
equilibri del sistema formativo, sia della formazione professionale
in generale, che della formazione edile in particolare.
L'occasione offerta dall'attuazione del Progetto Sperimentale
può rivelarsi una valida opportunità per sviluppare
maggior coesione tra le scuole del sistema Formedil, favorire
la formazione di nuove competenze, promuovere sinergie e
qualità nel settore.
Non dimentichiamo però che prima vanno risolte a
monte alcuni nodi essenziali come quello dell'"accreditamento"
previsto dalla recente normativa sulla riforma della Formazione
Professionale.Nello specifico, il progetto può trovare
una apprezzabile forma di diffusione e di sviluppo attraverso
i nuovi strumenti telematici (Internet), in modo che sia
accessibile in tempo reale dalle singole scuole, quindi
è possibile :
| 1. |
|
Rendere disponibile |
| |
• |
il progetto
generale ed i suoi moduli |
| |
• |
la banca dati dei materiali
didattici di supporto per tutte le scuole edili |
| 2. |
|
Implementarlo attraverso |
| |
• |
La raccolta di suggerimenti,
contributi critici, le riflessioni che scaturiranno
sull'argomento anche a seguito della sua attuazione |
| |
• |
La valutazione dei risultati
di monitoraggio in itinere e di validazione delle
attività attivate |
| |
• |
Lo sviluppo degli aggiornamenti,
implementazione e miglioramento del progetto e dei
suoi moduli |
| |
• |
L’avvio anche di
moduli per una formazione a distanza, attraverso la
disponibilità in rete intranet: |
|
|
|

|
| |
Un
contributo personale del coordinatore
Nell'intraprendere questo compito, nel corso del suo sviluppo,
ed a conclusione di questa prima fase, mi sono trovato più
volte a riflettere su alcune questioni che avevo nel tempo
sedimentato, attraverso la partecipazione, tra gli altri,
ad alcuni importanti (per me) momenti formativi sviluppati
prima con la SDA Bocconi di Milano e recentemente con il
Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università
di Padova, e che mi è parso opportuno porre a disposizione
degli interessati.
Cosa vuol dire preparare alle soglie
del 2000 ad un progetto sperimentale per apprendisti?
Per iniziare a rispondere mi è sembrato opportuno
rifarmi alla evoluzione di questa forma nel tempo.
Per millenni gli unici "apprendisti" sono stati
individui adulti o tutt'alpiù adolescenti.
Se guardiamo alla "storia" dell'apprendistato
dobbiamo registrare che fin dall'antichità, e segnatamente
poi dagli inizi del XIX secolo, l'adolescente (o l'adulto)
che volesse assumere il ruolo di allievo si ritrovava a
fare "l'apprendista" in una bottega, una fabbrica
o un’università.
La persona che doveva istruirlo non era un professionista
dell'insegnamento, ma, secondo i casi, un artigiano, un
tecnico, o uno scienziato, a cui non interessavano le modalità
con cui l'apprendista imparava: quello che contava era che
imparasse a fare quello che gli si chiedeva di fare e basta.
C'è da chiedersi se comunemente oggi ci troviamo
in una situazione molto diversa da quella del passato.
Ma come è evoluta la formazione?
Nell'antichità essa era sicuramente intesa come un
progetto unitario e globale di pensiero, e le "scuole"
erano animate collettivamente da gruppi di adulti che vi
si riconoscevano ed implicavano attivamente.
Interessante ricordare che etimologicamente la parola "scuola"
deriva dal greco “scholê” che significa
ozio, riposo, agio, svago, ed i verbo “scholàzein”
si traduce con: avere il tempo di occuparsi di una cosa
per divertimento.
Inutile far paralleli con la scuola moderna spesso luogo
di fatica, noia e costrizioni.
Secondo i grandi maestri ( Confucio, Lao-Tse, Socrate, Platone,
Aristotele, ecc.) l'unica forma di apprendimento era l'investigazione
attiva, la lezione ex-cathedra non aveva corso, se non come
arringa o sermone nelle piazze o nei templi.
Il pensiero moderno, nato intorno al XIV secolo, e tuttora
imperante, ha disarticolato le tre originarie componenti
fondamentali del conoscere:
- arte (tèchnê) abilità nel fare
- scienza (epistémê) sapere, conoscenza
- virtù (aretè) giudizio
che per il pensiero classico, erano assolutamente indissociabili.
La nascita poi nel XVII secolo della scuola pubblica,
governata dallo Stato (rivolta ai bambini), e fondata
su tali principi ha definitivamente spezzato il progetto
educativo globale classico, per frammentarlo in tante
tappe separate tuttora da barriere istituzionali (formazione
di base, iniziale, continua, permanente, …)
Nella scuola moderna in genere l'allievo è solo
richiesto di "sapere certe cose", poco importa
se saprà anche "come farle" e tantomeno
se sarà in grado di giudicare se "sono giuste";
anzi queste tematiche sono giudicate non pertinenti (se
non impertinenti), anche per gli insegnanti.
Il tempo è frammentato da campane che scandiscono
intervalli misteriosamente arbitrari, che non corrispondono
ai ritmi dell'attenzione o dell'interesse (e neanche alle
ore d'orologio) e soprattutto, che obbligano ogni volta
a cambiare argomenti, compagni di lavoro, fonti e docenti
di riferimento.
Sorvolando sulla qualità degli spazi e delle strutture
disponibili, ricorderemo solo che i programmi, le tematiche,
i problemi, le informazioni e le competenze non sono certo
scelte in funzione dello svolgersi degli interessi effettivamente
attivati o attivabili, ma sono imposti da autorità
il più delle volte sconosciute o irraggiungibili.
Vedremo se, cosa e come cambierà con le recentissime
riforme in itinere.
Ma non sono forse questi i principali
motivi che hanno portato e mantengono tuttavia una pesante
discrasia tra il mondo "scolastico" ed il mondo
del "lavoro"?
Nasce dunque da esigenze complesse la necessità
di formazione in ambito organizzativo
Ma come si è sviluppato
il concetto di Formazione Continua?
La Formazione Continua, intesa come impresa educativa
mirante all'aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze
individuali e collettive all'interno di un'organizzazione
professionale o produttiva, si impone all'attenzione solo
recentemente, nell'ultimo quarto di questo secolo.
Fino alla seconda guerra mondiale, la necessità
pratica della Formazione Continua non era affatto considerata.
La formazione professionale era concepita soltanto come
formazione iniziale.
Anzi all'inizio, dato il basso livello di qualificazione
richiesto agli operai, ed in genere anche agli impiegati
degli uffici, un semplice e rapido addestramento sul posto
di lavoro era considerato sufficiente.
L'addestramento non veniva affidato ad istruttori professionalmente
preparati, esso avveniva per semplice "immersione"
nell'ambiente di lavoro.
Nel migliore dei casi, un breve complemento veniva organizzato
nella scuola di base per favorire l'entrata nel mondo
del lavoro: queste classi erano chiamate di "avviamento".
Le prime scuole di formazione professionale tecnica sorgono
in Europa a partire dagli anni '50, ma vengono considerate
ancora appartenenti alla scuola di base.
Negli anni '60 l'accelerazione evolutiva del processo
tecnologico e produttivo da un lato, e l'insorgere di
rivendicazioni sindacali dall'altro, fanno prendere coscienza
della necessità di fornire ai dipendenti d'impresa
occasioni per i primi "corsi di aggiornamento professionale"
Nasce così sotto questa veste la prima versione
della Formazione Continua.
Vi è poi lo scossone del '68 e l'innesco negli
anni '70 di quel processo sempre più accelerato
di interconnesione, globalizzazione e mondializzazione
degli affari umani nel quale oggi siamo sempre più
ampiamente immersi.
La conseguenza fondamentale di questi fenomeni è
l'irriducibile imprevedibilità dei mercati, delle
economie e delle politiche.
Siamo agli anno '80.
La formazione continua abbandona la veste dell'aggiornamento.
In un tale contesto occorre insegnare ai collaboratori
non più o non solo a rispettare dei manuali, delle
procedure, ma a risolvere dei problemi sempre nuovi e
a gestire dei progetti che vengono continuamente messi
in discussione.
La formazione continua mira allora non più soltanto
a dei saperi tecnici, ma anche a dei cambiamenti comportamentali.
L'impiegato diventa una "persona", non più
soltanto un costo per l'impresa ma una risorsa: nasce
il concetto di "risorsa umana".
Sorge poi l'esigenza di coltivare non soltanto le competenze
personali, ma anche quelle collettive, quelle che fanno
si che l'azienda sia effettivamente un'impresa, intesa
non più come una somma provvisoria ed accidentale
di interessi e competenze personali, ma comuni: l'impresa
che apprende (learning organizzation)
E chiudiamo quindi il cerchio ritornando alla nostra prima
domanda:
Cosa vuol dire preparare alle
soglie del 2000 ad un progetto sperimentale per apprendisti?
E l'apprendista impiegato è un adolescente o un
adulto?
I nostri allievi "apprendisti" sono sicuramente
provenienti da un istituto medio superiore e normalmente
sono maggiorenni.
Anche se l'adultità sarebbe un concetto interessante
da approfondire, qui il problema ci interessa in maniera
diretta non in termini accademici, ma per definire una
relazione tra le modalità di apprendimento e le
metodologie didattiche da adottarsi.
Nelle teorie della formazione, così come sedimentatesi
nei secoli, occorre attendere l'inizio del XIX secolo
perché compaiano le prime teorizzazioni sull'apprendimento
adulto formulate da Knapp (andragogia) e da Herbat, per
giungere a quelle del sociologo Rosenstock, che intorno
al 1920 teorizza come indispensabile applicare specifiche
metodologie didattiche per gli adulti, per arrivare infine
agli anni '70 quando il termine "andragogia"
viene sostituito da "educazione o formazione degli
adulti".
Ed è soprattutto il contributo del costruttivista
Piaget e dei suoi epigoni a porre dei punti fermi sulle
modalità di apprendimento:
1. Sullo sviluppo dell'intelligenza
- Piaget, aveva già spiegato che lo sviluppo
dell'intelligenza (la forma più evoluta di adattamento)
sia nel bambino che nell'adulto, altro non è
che il passaggio da strutture operative più semplici
ad altre più complesse, e come sia "l'interazione
dialettica tra assimilazione e processi di accomodamento
che sviluppa la proprietà adattiva nel comportamento
cognitivo", e poi mostra come " ..è
adattandosi alle cose che il pensiero si organizza,
ed è organizzandosi che struttura le cose".
2. Sull'interazione tra sistemi biologici:
- Nel '75 Piaget afferma che "un sistema biologico
(Piaget è un biologo) o cognitivo, può
interagire in modo costruttivo solo con quei sistemi
con cui ha già deciso di interagire". Tutto
ciò significa che il docente deve modellare il
suo intervento sulle potenzialità concrete del
discente non solo per ragioni motivazionali, ma addirittura
per ragioni biologiche
3. Sull'ambiente di apprendimento
- Se l'ambiente viene definito come "l'insieme
di vincoli in seno al quale l'organismo si trova ad
operare", ciò rivoluziona la figura dell'insegnante:
non più "istruttore", ma "componente",
insieme a molteplici altre, dell'ambiente entro il quale
l'allievo deve cercare di conservare la propria autonomia.
- Differenza fondamentale tra la Pedagogia Tradizionale
e la Peda-andragogia Attiva è il ruolo attribuito
all'ambiente-insegnante nella spiegazione dei processi
evolutivi:
- per la Pedagogia Tradizionale l'ambiente insegnante
è la causa dell'adattamento-apprendimento
- ß per la Peda-andragogia Attiva l'adattamento-apprendimento
è la risposta attiva ed autonoma dell'allievo
ai vincoli che l'ambiente insegnante gli impone.
Secondo questa teoria l'insegnante non ha alcun mezzo
per sapere in precedenza in che direzione si orienterà
il processo apprendimento che egli cerca di provocare.
Ogni volontà di programmazione delle tappe di
uno specifico apprendimento sarà dunque inevitabilmente
alienata rispetto ai processi effettivi di elaborazione
della conoscenza, e ciò vale sia per l'adulto
che per i bambini.
Ultimamente, sviluppando le teorie di Piaget, la Psicologia
Culturale (Fabbri & Munari 1984) ha sostenuto che
lo sviluppo cognitivo è una produzione reciproca
tra il soggetto e il suo ambiente fisico e sociale. Ciò
significa che ogni apprendimento è sempre accompagnato
da cambiamenti, spesso profondi, che intaccano l'intera
personalità, e ciò sia per l'adulto che
per il bambino.
Per la Psicologia Culturale non c'è differenza
nell'apprendimento adulto e bambino: la conoscenza è
sempre una decisione strategica, che implica la totalità
della persona nel suo modo di ragionare, percepire, sentire,
giudicare.
Inoltre, il carattere tipicamente contestuale e contingente
dei criteri che possono guidare tale decisione può
rendere assolutamente imprevedibile la direzione verso
la quale si può orientare l'evoluzione cognitiva
del soggetto, nel nostro caso dell' "allievo"
Possiamo allora distinguere tra
Educazione e Formazione?
Si direbbe di no.
Anche se questa distinzione, è oggi molto diffusa
oltreoceano, ed anche in Italia, ed è abbastanza
frequente l'uso del termine "formazione" per
indicare che l'azione in atto non coinvolge “totalmente”
il formando, per cui l'uso di questi termini sottintende:
- per Formazione (training) : che esse ha come obiettivo
principale "solo" l'addestramento (più
facilmente, immediatamente e oggettivamente misurabile)
- per Educazione (development) : che essa ha come obiettivo
principale il "vero" sviluppo risultante da
un processo di autentico apprendimento (non più
facilmente, né immediatamente, né oggettivamente
misurabile)
Ma, per quanto abbiamo appena detto, sappiamo che le frontiere
tra addestramento ed apprendimento (formazione/educazione)
in realtà non sono così nettamente definite
ed anzi sfumano in un continuum, un mix, in cui questi
aspetti sono sempre presenti ma di volta in volta in misura
diversa.
In definitiva cosa caratterizza
la formazione che ci apprestiamo ad erogare?
Certamente le metodologie didattiche applicabili per l'adulto.
Knowles, una delle figure più note nel campo della
formazione dell'adulto, nel 1973 pubblica un lavoro (the
adult learner: a neglected species) in cui sostiene che
l'insegnamento rivolto all'adulto deve differenziarsi
da quello normalmente praticato nella scuola per almeno
sei ragioni di seguito riassunte:
1) L'adulto non accetta di mobilitare le proprie energie
per apprendere, se non percepisce chiaramente il senso
e l'utilità che può avere per lui l'apprendimento
che gli viene proposto
2) L'adulto si considera una persona autonoma e responsabile,
e tollera difficilmente che gli si imponga un modo di
fare e degli obiettivi senza che questi siano stati
preventivamente discussi e negoziati con lui
3) L'adulto è portatore di un bagaglio importante
di esperienze, a cui è affezionato e che si è
già dimostrato utile per risolvere la maggior
parte dei problemi, l'apprendimento propostogli deve
dunque potersi integrare o comunque tener conto di questo
bagaglio esperienziale
4) L'adulto si implicherà nel processo di apprendimento
soltanto quando la sua situazione professionale o personale
gli avrà fatto percepire e comprendere la necessità
di farlo
5) Il modo di apprendere dell'adulto non è centrato
su contenuti, temi o problematiche astratte, ma su casi
concreti e procedure di azione effettiva
6) La motivazione principale per la quale un adulto
apprende è il desiderio di una maggiore autonomia
e la ricerca della realizzazione personale; diplomi,
guadagni o promozioni possono essere degli incentivi,
ma solo secondari.
Knowles propone anche di sostituire il termine di "
insegnante " con il termine di “facilitatore
"
In definitiva Knowles, come i maestri dell'antichità,
considera l'apprendimento come frutto di una ricerca attiva
ed autonoma, suggerita dal maestro-facilitatore, ma mai
completamente guidata e controllataConsiderazioni
Non vorrei trarre conclusioni, meglio sarebbe avviare
un momento di approfondimento collegiale su queste ed
altre tematiche della formazione.
Mi è sembrato opportuno, e forse necessario, rendere
nota questa serie di appunti da me raccolti ed esposti
in maniera forzatamente approssimativa, esponendomi magari
a qualche rischio di incomprensione o accusa di leggerezza:
d'altro canto non mi proponevo di dare lezioni.
Mi è parso che queste concezioni in realtà,
per la loro forza, e vista l'autorevolezza delle fonti
da cui derivano, possono stravolgere completamente la
concezione e le pratiche della progettazione formativa
e dell'insegnamento come comunemente inteso
E poi dovrebbero farci riflettere molto sulle pratiche
che anche noi stessi, adottiamo correntemente nella preparazione
e nell'erogazione delle azioni formative, che in un futuro,
quanto mai prossimo, dovremo forzatamente riorganizzare
e riqualificare.
Tutto ciò, potrà allora, col contributo
attivo di tutti gli interessati:
- rafforzare il sistema del Formedil
- promuovere una positiva evoluzione del sistema formativo
edile nel suo complesso, verso una più ampia
e diffusa qualificazione
- fornire un contributo concreto allo sviluppo del settore
edile mettendolo in grado di reggere le sfide del mercato,
e che sarà tanto più apprezzato ed indispensabile
in quanto più qualificato ed efficace
Vincenzo Colardo
|
  |
|
|